Ora facciamo un’analisi storica per capire meglio il potere militare nel contesto di quel decennio che va dal 1968 al 1978:

L’Italia ha il più forte Partito Comunista cattolico dell’Occidente. Uno “spregiudicato” gruppo di politici cattolici guidati da Aldo Moro, attraverso un compromesso, vuole portare il PCI e i cattolici al governo. Questo per la Nato anticomunista (USA) e per l’URSS è inconcepibile: gli statunitensi non possono permettere ai comunisti (anche se cattolici) di occupare posti al governo, neppure con sottosegretari; i sovietici non possono tollerare che un “suo” partito si socialdemocratizzi, minando la base del comunismo internazionale. Anche Israele è preoccupata, poiché l’ingresso dei comunisti in un governo italiano avrebbe significato un avvicinamento dell’Italia alla causa palestinese. Per riportare l’Italia sulla rotta di Yalta (ancora oggi, nei manuali di storia la conferenza di Yalta viene descritta come l’evento epocale in cui i tre leader mondiali si spartirono l’Europa in sfere d’influenza, benché fosse già chiaro, sulla base dell’andamento militare del conflitto, che l’Unione Sovietica sarebbe stata potenza dominante nell’Europa), ma anche per mantenere gli altri stati europei sulla stessa strada, si utilizzano eserciti segreti (nuclei clandestini dello stato, doppio Sid – servizio segreto, Gladio), che infiltravano e minacciavano i politici (lo stesso Moro fu più volte “avvertito” che il suo compromesso storico non piaceva alla Nato anticomunista).
In questo senso un manuale, il Field manual 30-31, dove 30 indica che l’area d’interesse sono i servizi segreti militari, mentre 31 le operazioni speciali, può illuminare la nostra ipotesi, ricordandoci che copia di questo manuale fu ritrovata nella villa di Arezzo del massone Gran Maestro della P2 Licio Gelli nel 1981 (foto sopra). Infatti tra le altre cose, il manuale prevede “delle infiltrazioni nei gruppi dell’estrema sinistra sino a prenderne la leadership”. Dunque: “eliminato” l’irriducibile Giangiacomo Feltrinelli, che aveva contatti col terrorismo internazionale, Hyperion acquisisce questi rapporti; “rimossi” Curcio e Franceschini, al loro posto subentrano Mario Moretti e, dopo il suo arresto, Giovanni Senzani. Il doppio cambio di leadership contribuisce a un cambio di regia sia a livello internazionale sia nazionale, diventando un’operazione utile per strumentalizzare le organizzazioni eversive. Il tema della lotta armata, all’epoca, percorre tutta l’ala più radicale della sinistra extraparlamentare: il gruppo “22 ottobre” di Genova ha già intrapreso quella strada nell’autunno 1969, seguito poco dopo da Feltrinelli coi suoi GAP, dopo la Strage di piazza Fontana.
Il Superclan si troverà al centro di molte indagini e gravi sospetti (per esempio di essere una sorta di “centrale di controllo” del terrorismo, con legami coi servizi segreti). La prima azione documentata a firma del nuovo gruppo (il cui nome all’inizio è declinato al singolare, Brigata rossa) è l’incendio dell’auto di un dirigente della Sit Siemens a Milano, il 17/9/1970. Il simbolo che adottano è una stella a 5 punte, asimmetrica, disegnata dentro un cerchio. La denominazione brigate è un omaggio alle formazioni partigiane che combatterono durante la guerra di Liberazione. I brigatisti infatti vedono se stessi come eredi di quella tradizione, e alcuni di loro intrattengono legami con ex combattenti facenti parte della minoranza che coltiva il mito della “Resistenza tradita” (perché col fascismo non si era abbattuto anche il sistema capitalistico, come una parte dei comunisti e socialisti avevano sperato) e si rappresentano come i protagonisti di una nuova Resistenza (è anche il titolo di una pubblicazione di cui producono due numeri nella primavera del 1971: la loro ultima iniziativa legale). Dal punto di vista ideologico, le BR si ispirano al marxismo-leninismo e alle esperienze di guerriglia in America Latina, in particolare ai Tupamaros uruguayani e ai metodi di guerriglia codificati dal brasiliano Carlos Marighella in un manualetto molto popolare negli anni ‘70, posizionandosi, come scrivono nell’aprile 1971, «nel quadro della guerra mondiale imperialista che oppone la controrivoluzione armata alla lotta rivoluzionaria dei proletari, dei popoli e delle nazioni oppresse.

È la resistenza orientata dalla Cina rivoluzionaria del presidente Mao […] capeggiata dal Vietnam e dai popoli rivoluzionari dell’Indocina. È la resistenza dei popoli palestinesi e dell’America Latina […] nelle metropoli imperialiste, nei ghetti neri e nelle città bianche». Le BR collocano se stesse all’interno di una tradizione comunista “eretica”, radicalmente ostile al PCI. Come le altre organizzazioni terroristiche, sono influenzate in modo profondo anche dal filone di pensiero operaista sviluppatosi a partire degli anni ‘60, che teorizzava la “centralità operaia”, la necessità di un’azione diretta dei lavoratori, senza l’intermediazione del sindacato, anche in forme nuove e radicali, ed era caratterizzato dal rifiuto (quando non dall’odio) del riformismo: non a caso, molti militanti di Potere operaio, per esempio, uno dei gruppi principali dell’ultrasinistra ispirato a questo filone di pensiero, andranno a ingrossare le file delle BR nel corso degli anni ‘70.

Nelle neonate BR confluiscono esperienze e culture politiche diverse. Renato Curcio, con Margherita Cagol e Paola Besuschio, ha frequentato la nuova Facoltà di Sociologia a Trento, uno dei luoghi dove più accesa è stata la contestazione del Sessantotto, e ne è stato uno dei leader, accanto a Mauro Rostagno, ma il grosso dei militanti brigatisti non vengono da lì. Ci sono i transfughi del PCI, come Franceschini e altri reggiani, insieme ai giovani cresciuti nei fermenti sociali del cattolicesimo di sinistra, influenzati dalla teologia della liberazione di Camillo Torres diffusa in America Latina e da un’interpretazione radicale del messaggio evangelico. Nel frattempo, Corrado Alunni, Susanna Ronconi e Fabrizio Pelli escono dalle BR per intraprendere un percorso autonomo, che li porta verso Prima linea e poi alla creazione delle Formazioni Comuniste Combattenti (FCC). Dopo la nuova ondata di arresti, nella primavera del 1976 i brigatisti in libertà sono una ventina (tra cui il nuovo leader Mario Moretti, che con Lauro Azzolini, Franco Bonisoli e Rocco Micaletto forma il Comitato esecutivo, e militanti come Walter Alasia, Maria Carla Brioschi, Riccado Dura, Raffaele Fiore, Patrizio Peci. Anche grazie a un’ampia rete di simpatizzanti e fiancheggiatori, però, le BR anziché fermarsi alzano il tiro: dopo alcune azioni congiunte coi Nuclei armati proletari, l’8 giugno 1976, a Genova, uccidono il Procuratore generale di Genova Francesco Coco e i suoi due agenti di scorta. Magistrato di idee conservatrici, Coco aveva disposto di ricatturare i membri del gruppo “22 ottobre” rilasciati in cambio di Sossi, in base alla considerazione che l’ostaggio aveva riportato alcune lesioni fisiche.
Le BR avevano già ucciso: si erano assunte la responsabilità dell’omicidio di due missini, Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola (foto sopra), nel corso di un’incursione nella sede del MSI di via Zabarella a Padova, il 17/6/1974; poi avevano assassinato l’Appuntato dei cc Giovanni D’Alfonso e l’agente Antonio Niedda nel corso di scontri a fuoco, nel 1975, ma l’uccisione di Coco è il primo omicidio politico pianificato delle BR. Il clima generale, d’altro canto, è cambiato: uno dei nuclei da cui scaturirà Prima linea era già passato all’omicidio politico il 29/4/1976, uccidendo a Milano il Consigliere provinciale del Movimento sociale italiano (MSI) Enrico Pedenovi, e i NAP seguiranno a stretto giro, innescando una spirale di morte che durerà per anni. Il fatto che le BR, ridotte al lumicino, siano riuscite a riprendere rapidamente vigore, insieme alla svolta in senso decisamente militarista impressa da Moretti, ha indotto alcuni studiosi (in primis il politologo Giorgio Galli, tra i primi studiosi del cosiddetto partito armato del terrorismo di sinistra), a ipotizzare che una parte dei servizi e delle forze di sicurezza abbia praticato nei loro confronti una sorta di stop and go, calibrando ad arte la repressione, così da poter strumentalizzare a fini politici la tensione creata dall’escalation di attentati dei terroristi di sinistra. La scelta di smantellare il nucleo speciale di Dalla Chiesa nel luglio 1975, nonostante i suoi successi, ha accresciuto i sospetti in questo senso, ma ad oggi non esistono evidenze decisive (anche per l’accesso limitato o impossibile alle carte dell’arma, del viminale e dell’intelligence), e questa tesi ha molti vivaci oppositori. Si tratta di un tema delicato, ancora tutto da studiare. Nel 1977 le BR aumentano in modo considerevole le proprie dimensioni grazie al notevole afflusso di militanti fuoriusciti dall’area dell’Autonomia operaia organizzata, soprattutto dopo la repressione del movimento del Settantasette. L’allora Ministro dell’Interno Cossiga ha riconosciuto il nesso tra le politiche d’ordine pubblico fortemente repressive messe in campo per stroncare la violenza di piazza e l’ingresso di molti militanti nelle BR o in Prima linea, con il restringersi degli spazi d’azione collettiva. Forte di questa crescita, nel 1977 l’organizzazione si lancia in campagne particolarmente aggressive: quella contro il processo al “nucleo storico” in corso a Torino e quella contro i giornalisti. Per sabotare il processo torinese e impedirne il regolare svolgimento, i brigatisti rifiutano la nomina dei difensori d’ufficio e il 28 aprile, a scopo intimidatorio, uccidono Fulvio Croce, Presidente dell’Ordine degli avvocati. Il processo si blocca per l’impossibilità di formare una giuria popolare: i cittadini estratti a sorte per l’incarico, terrorizzati dalle intimidazioni brigatiste, rifiutano di presentarsi, producendo una pioggia di certificati medici per «sindrome depressiva», mentre intellettuali del calibro di Sciascia sostengono pubblicamente come non valga la pena rischiare di morire per lo stato italiano, scatenando un acceso dibattito. Il processo riparte solo nel 1978, quando, dopo 134 defezioni, si riesce a formare una giuria, di cui fa parte anche la deputata radicale Adelaide Aglietta che, estratta a sorte, accetta senza esitazioni.

La campagna per “disarticolare la funzione controrivoluzionaria svolta dai grandi media” invece, vede il ferimento alle gambe (per cui si conia il tragico termine gambizzazione) del vicedirettore del «Secolo XIX» Vittorio Bruno a Genova, il 1° giugno, della firma del «Corriere della Sera» Indro Montanelli a Milano, il 2, e del direttore del TG1 Emilio Rossi a Roma il giorno successivo, e culmina con l’omicidio del vicedirettore del quotidiano «La Stampa» Carlo Casalegno, che muore il 29 novembre a Torino dopo 13 giorni di agonia. Nel febbraio del 1978, con una nuova “risoluzione strategica”, le BR lanciano la “campagna di primavera”, che culmina col sequestro e l’omicidio di Aldo Moro e della sua scorta nella Strage di via Fani il 16/3/1978. Il Governo di solidarietà nazionale guidato da Andreotti, insediatosi proprio quel giorno (DC con sostegno esterno PCI) sceglie la “linea della fermezza”, ossia di non trattare con le BR, ma nelle settimane crescerà il fronte della trattativa, guidato dai socialisti (le ricerche recenti, però, hanno documentato come, dietro le quinte, vi siano invece state trattative coi terroristi).
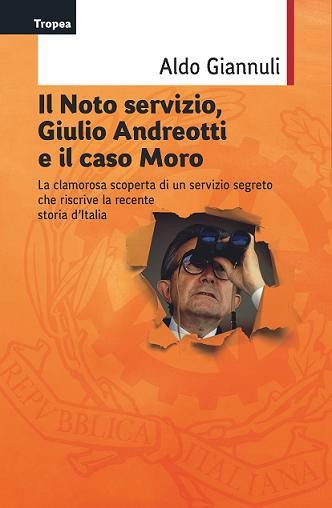
I 55 giorni trascorsi da Moro nella “prigione del popolo” brigatista, pesantemente influenzati dalla dimensione spionistico-informativa assunta dal sequestro nel momento in cui cominciarono gli interrogatori del prigioniero, detentore di conoscenze delicatissime in materia di politica interna e internazionale, si concludono il 9 maggio con l’uccisione dell’ostaggio e il ritrovamento del suo cadavere nel bagagliaio di una Renault rossa in via Caetani, nel centro della Capitale.
In quelle settimane, le altre colonne BR, per aumentare la pressione sulle istituzioni, feriscono sei persone e ne uccidono due, l’agente di custodia Lorenzo Cutugno a Torino (11 aprile) e il Vicecomandante degli Agenti di custodia presso il carcere di S. Vittore, Maresciallo Francesco Di Cataldo a Milano (20 aprile): l’arresto di un numero crescente di militanti rende il sistema carcerario un obiettivo sempre più centrale per le BR come per le altre organizzazioni terroristiche.
Il 1980 è l’inizio della fine. L’arresto di Patrizio Peci, il 19 febbraio, avrà conseguenze fatali, perché il brigatista comincia quasi subito una collaborazione con cc e magistratura.
Le BR però continuano a uccidere: l’anno si avvia nel segno dell’attacco alle forze dell’ordine, con l’omicidio di tre poliziotti a Milano e due carabinieri a Genova nel mese di gennaio, prosegue con “delitti eccellenti” come l’omicidio del Vicepresidente del CSM Vittorio Bachelet, il 12 febbraio 1980, e si conclude col sequestro del magistrato Giovanni D’Urso (12 dicembre 1980 – 15 gennaio 1981), un grosso successo d’immagine per l’organizzazione, che ottiene il duplice risultato di ascriversi il merito della chiusura del supercarcere dell’Asinara in cambio del rilascio dell’ostaggio (sebbene il governo affermasse che era previsto da tempo) e di lacerare la società italiana che, ancora traumatizzata dalla vicenda Moro, si divide sull’opportunità o meno di diffondere attraverso i media i messaggi dei brigatisti.

Nel libro “Il memoriale della Repubblica” (foto sopra), Gotor annota: “È pur vero che sulla scomparsa degli originali di Moro e sulle autentiche ragioni che indussero i brigatisti a non distribuirli durante e dopo il sequestro, è calata una spessa coltre di silenzio poiché si è verificata una imbarazzante quanto drammatica eterogenesi dei fini tra il governo, i brigatisti rossi, i partiti politici, i familiari e gli amici di Moro: un’eterogenesi così facilmente prevedibile nel suo meccanismo formativo e autobloccante da indurre a pensare che gli originali degli scritti di Moro, nella loro versione integrale, non siano rimasti in mano italiana”. Il nuovo materiale scoperto nel 1990 contiene importanti riferimenti ai dirigenti dei servizi segreti,con severe valutazioni su taluni leader democristiani e contengono notizie ritenute “segreto di stato”. In queste pagine Moro rivela, tra l’altro, l’esistenza della struttura dell’Organizzazione Gladio, ben nota ai servizi segreti, ma per quarant’anni nascosta al Parlamento italiano. Il memoriale affronta 16 questioni, a partire dall’origine del centro-sinistra e dal colpo di stato chiamato Piano Solo (fatto nel 1964 da Giovanni de Lorenzo durante il suo incarico di comandante generale dell’arma dei cc) per volere del presidente della Repubblica Antonio Segni (foto sotto). Moro evidenzia, tra le ragioni di crisi del suo primo governo, l’ingerenza del commissario CEE Robert Marjolin, cui ora attribuisce un rilievo forse maggiore di quello effettivamente rivestito. A inizio sequestro Moro ragiona nei termini abituali e, sia pure con qualche distinguo, “tutela” il vecchio sistema di potere doroteo. Precipitato nella condizione di reietto e sconfessato dal suo stesso partito, svela il “sommerso” della crisi politica dell’estate 1964.

La principale novità riguarda proprio Antonio Segni, rappresentato quale uomo di potere che persegue con ostinazione una strategia Atlantica anticomunista (Nato) contraria al centro-sinistra (cattolici), contravvenendo al ruolo di garante delle istituzioni. La versione del 1990 del memoriale Moro sviluppa ulteriormente queste riflessioni: «Il tentativo di colpo di stato nel ’64 ebbe certo le caratteristiche esterne di un intervento militare, secondo una determinata pianificazione proprio dell’arma dei cc, ma finì per utilizzare questa strumentazione militare essenzialmente per portare a termine una pesante interferenza politica rivolta a bloccare o almeno fortemente dimensionare la politica di centro-sinistra, ai primi momenti del suo svolgimento. Questo obiettivo politico era perseguito dal Presidente della Repubblica On. Segni, che questa politica aveva timidamente accettato in connessione con l’obiettivo della presidenza della repubblica. Moro parla chiaramente di tentativo di colpo di stato: Segni era «estremamente ansioso» e «fortemente preoccupato», «terrorizzato da consiglieri economici che gli agitavano lo spettro di un milione di disoccupati», influenzato dai nostalgici del centrismo che «gli presentavano artatamente a fosche tinte l’avvenire dello Stato». «Nell’eccitazione della malattia» il presidente ingigantisce le preoccupazioni per l’ordine costituzionale e vuole sbarrare la strada a Moro. Nel memoriale Moro sono contenute anche preziose analisi di Moro su temi quali Giulio Andreotti e il rapporto con Michele Sindona, la strategia della tensione, lo scandalo Lockheed, la strage di Piazza Fontana, lo scandalo Italcasse e l’Operazione Gladio; nonché giudizi molto pesanti sia politicamente che umanamente riguardo a Giulio Andreotti e Francesco Cossiga.

La Commissione stragi acquisì il materiale dalla Digos nel febbraio 2001, dopo che era stato dato per disperso, lo riordinò per tema confrontando le Stesura D e C (cioè il testo che fu diffuso dal Ministero dell’Interno il 17/10/1978, che come detto era poco ordinato). Gli scritti sono studiati e ricostruiti filologicamente da Francesco Maria Biscione, consulente della Commissione stragi e collaboratore dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana e pubblicati nel libro “Il memoriale di Aldo Moro”, rinvenuto in via Monte Nevoso a Milano. Dall’analisi del testo Biscione ricostruisce il lavoro come la risposta da parte di Moro a 16 domande poste da un questionario brigatista. Per quanto riguarda la completezza del memoriale Biscione sottolinea che in 25 occasioni Moro rimanda a risposte realmente presenti, mentre in due occasioni, quando si riferisce ai servizi segreti in Libia e ai rapporti tra Giulio Andreotti e gli stessi servizi, non si trovano i brani a cui rimanda. Sulle differenze tra le stesure vennero aperte varie interrogazioni della Commissione, in cui venne ascoltato anche il capo dell’organizzazione Gladio. Nella sentenza del processo Andreotti, pronunciata dalla Corte di Assise di Perugia il 13/2/2003, emergono una serie di conclusioni sul Memoriale Moro. La comparazione tra i due scritti, tuttavia, permette di affermare, seguitano gli stessi giudici, che quello rinvenuto nel 1990 contiene notizie più pregnanti ed organiche rispetto a quello del 1978.

Ed invero, sul caso Italcasse se da un lato nello scritto del 1978 vi è un riferimento al ruolo del debitore Caltagirone, che tratta su mandato politico la successione del direttore generale dell’Italcasse, nello scritto del 1990 si fa un maggior cenno al motivo per cui Caltagirone ha mandato politico nella nomina del direttore dell’Italcasse e, cioè, la sistemazione della propria posizione debitoria. Parimenti sui rapporti tra Michele Sindona e Giulio Andreotti; mentre nello scritto del 1978 si parla quasi occasionalmente del viaggio di Giulio Andreotti negli USA, per incontrare Michele Sindona, e della nomina di Mario Barone (come pretesa di Michele Sindona per la sua collocazione all’interno del Banco di Roma, quale contropartita per l’elargizione di £ 2.000.000.000, in occasione della campagna per il referendum per il divorzio, da parte di Sindona, e delle ripercussioni che una tale nomina politica avrebbe avuto negli equilibri del Banco di Roma) si parla nell’ambito della valutazione della figura di Amintore Fanfani, nello scritto del 1990 i rapporti tra Michele Sindona, Mario Barone e Giulio Andreotti vengono organicamente trattati come espressione della personalità di Andreotti da lui definito nello scritto del 1978: “Un regista freddo, imperscrutabile, senza dubbi, senza palpiti, senza mai un momento di pietà umana. È questo l’on. Andreotti del quale gli altri sono stati tutti gli obbedienti esecutori di ordini” e continua affermando che “Andreotti è restato indifferente, livido, assente, chiuso nel suo cupo sogno di gloria“.

Giudizio completato nello scritto del 1990 quando, dopo avere unitariamente analizzato i fatti riferiti a Giulio Andreotti e avere tra questi inserito anche l’intervista in cui denunciava l’appartenenza di Guido Giannettini (a sinistra nella foto con Franco Freda), come agente del SID, afferma che quelli sono tutti segni di un’incredibile spregiudicatezza che deve aver caratterizzato tutta una fortunata carriera (che Moro non gli ha mai invidiato) e della quale la caratteristica più singolare è che passi così frequentemente priva di censura o anche solo del minimo rilievo. Tra gli argomenti trattati nel memoriale, citiamo: l’organizzazione Gladio, un esercito occulto (stay-behind) presente in molti paesi europei e finanziato dalla CIA, col compito di resistere almeno 5 giorni in caso di invasione comunista, la cui esistenza è stata resa pubblica poche settimane dopo il ritrovamento del memoriale; Piano Solo; elementi della cosiddetta strategia della tensione; Italcasse, Caltagirone e la corrente andreottiana. «Riguardai per l’ennesima volta le vecchie foto e notai che oltre Memeo, con l’arma a braccia tese, nascosto tra gli alberi, c’era un giovane con i capelli chiari intento a fotografare…».

Milano, 14/5/1977. «Un giovane fotografo dilettante di nome Paolo Pedrizzetti immortala un’immagine destinata ad entrare nella storia del nostro Paese. Sono le ore 17:45 e in via De Amicis un uomo dal volto parzialmente coperto sta impugnando una pistola. La punta ad altezza d’uomo, con le braccia tese, pronto a sparare. Si tratta di Giuseppe Memeo, detto “il terùn”, 19 anni, militante dei PAC (Proletari Armati per il Comunismo). Nel mirino del giovane sovversivo c’è un agente di polizia e Memeo non è l’unico ad essere armato in quel tratto di strada. Anche altri attivisti stanno sparando. Ma perché? Cosa sta accadendo? Conti, a differenza degli altri fotografi, aveva puntato il suo obiettivo anche in avanti, verso la polizia, aveva fermato l’inizio dell’attacco e ripreso in tre fotogrammi lo sparatore che si era portato subito più avanti di tutti. Era un ragazzo che non compariva nelle altre foto, con un passamontagna chiaro e un’automatica in mano: Mario Ferrandi, un giovane che si era da tempo staccato dalla lotta armata, aveva sparato il colpo mortale. La fotografia più famosa, pubblicata in tutto il mondo, che riprendeva Memeo con l’arma a braccia tese, lo capimmo allora, era stata scattata in un momento successivo, durante la ritirata del gruppo, quando Custra era già stato colpito: qualche volta anche le immagini icone ingannano. Così l’indagine ebbe fine».
.
2024/25: Report – Il laboratorio
Di Giorgio Mottola, da Report del 03/11/2024. Report ha ricostruito come negli ultimi vent’anni Israele si sia trasformato nel laboratorio politico dell’estrema destra internazionale mentre a Gaza le industrie belliche e della cybersecurity israeliane testano le loro armi e i loro prodotti, che vengono poi rivenduti all’estero e anche in Italia.
https://www.raiplay.it/video/2024/11/Il-laboratorio—Report-03112024-fb8a908b-7b06-467b-a076-b3fafb1ef0e4.html
.
A differenza della generazione degli anni ’70, oggi non è più obbligatorio il servizio militare, i giovani non hanno subito il ‘lavaggio del cervello’ del soldato, e l’oratorio non è più in auge, quindi non si è abituati a farsi comandare o ad eseguire il nonnismo (GERARCHIA MILITARE) dall’alto, agendo senza pensare. Noi Anarchici poi, non saremmo mai entrati in un’organizzazione gerarchica come le Br, perché siamo allergici alle gerarchie, siamo abituati a usare il nostro di cervello. Non siamo né servi, né capi e nemmeno padroni! Riteniamo indispensabile conoscere la Storia, approfondirla, collegare tra loro gli avvenimenti e i personaggi, cercare di capirli, di interpretarli, in particolare partendo dalla tragica dittatura fascista, dalla Resistenza, dalla II guerra mondiale, passando dagli “anni di piombo”, fino ai giorni d’oggi (III guerra mondiale), per non ripetere gli stessi errori del passato.
.
La morale borghese è per me l’immoralità
contro la quale si deve lottare: la morale
fondata sulle nostre ingiuste istituzioni sociali,
quali la religione, la patria, la famiglia,
la cultura, insomma, quelli che si usa
chiamare i “pilastri della società”.
L. Bunuel
.
Solidarietà alle compagne e ai compagni Anarchici che hanno lottato per la nostra libertà e sono stati ingiustamente arrestati.
. Cultura dal basso contro i poteri forti
Rsp (individualità Anarchiche)