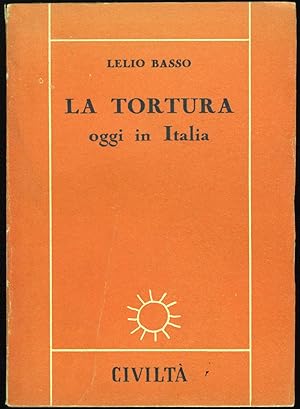25 giugno 2015: Agenti di polizia fuori dall’Expo per distribuire volantini contro la legge sul reato di tortura…
A spiegare le ragioni della manifestazione c’è quell’ ipocrita merdaccia di Stefano Paoloni, segretario del Sap, sindacato autonomo di polizia: “Gli agenti si scagliano contro i numeri identificativi. “L’introduzione del reato ingesserebbe l’operato delle forze di polizia” . …
Gli sbirri hanno inscenato una manifestazione allegorica perché sono preoccupati per la loro impunità, che verrebbe a meno se si attiva la legge sul reato di tortura. Le loro violenze e torture fatte alla povera gente o a cittadini comuni verrebbero processate, non finirebbero facilmente in galera, ma almeno si darebbe nome e cognome agli “abusi di potere”.
Ora torniamo indietro nella Storia per capire da dove nasce l’ignobile abitudine sbirresca di usare la sopraffazione e la violenza sul più debole:
STATO DI POLIZIA
La “tortura moderata” della polizia fascista
Nel 1953 l’Unione nazionale di polizia, non volendo “rimanere inerte di fronte all’attuale situazione che minaccia di precipitare il Paese nella guerra civile” denunciò all’autorità giudiziaria LeIio Basso, “visionario parlamentare estremista” autore di “un indegno libello […] nel quale ha fatto strazio degli organi di polizia […] accusandoli di atrocità, di sevizie e di delitti gravissimi con la connivenza del governo, contro il quale scaglia le più volgari contumelie. La reputazione, la morale, l’onore degli appartenenti alla polizia, sono coscientemente lesi, al punto che essi, nel libello, appaiono una associazione mafiosa, che attua i più svariati sistemi di barbarie e terroristica tortura inquisitoria, per strappare una confessione, o per procurarsi le prove di un delitto, o per imbastire un procedimento penale a carico di innocenti”.
Nessuna più efficace e sintetica descrizione della nostra polizia di quella testé data dalla rivista ufficiosa “Ordine Pubblico.” Il libello in questione (La tortura oggi in Italia) aveva costituito una delle più significative iniziative seguite allo scandalo suscitato dal caso Egidi, dal quale prese anche le mosse una commissione ministeriale d’inchiesta. Nel processo Egidi (gennaio 1952) furono portate alla ribalta, clamorosamente, tutte le caratteristiche dei metodi “di indagine” della pubblica sicurezza. Guidata da un questore senza scrupoli (Polito) e diretta da un commissario ex torturatore fascista (Barranco) la squadra mobile romana, trovandosi con l’assassinio della piccola Annarella Bracci al suo 26° delitto impunito, decise che il malcapitato Lionello Egidi avrebbe dovuto essere il “reo confesso” che avrebbe risollevato le sorti malmesse della polizia criminale della capitale. “Egidi deve confessare,” ordinò il questore: Barranco si incaricò di eseguire le direttive di Polito. Ed Egidi “confessò”; ma sopravvennero clamorose ritrattazioni dell’imputato, rese più credibili dalle evidenti tracce di violenza subita, e, malgrado l’appassionata serie di arringhe del p.m. tese a dimostrare che la confessione di Egidi era valida, anche se si fosse adoperata qualche “tortura blanda” per estorcergliela, Egidi andò prosciolto, sia pure per insufficienza di prove. Al di là del banale caso in sé, il processo Egidi rappresentò una data: in esso, oltre alla rivelazione esplicita dei mezzi e dei metodi meschini di azione della polizia italiana nello svolgere indagini: violenze psicologiche e fisiche, abuso di potere ecc. Gli sbirri sono colpevoli inoltre di connivenza con la magistratura, soprattutto nell’organismo del pubblico ministero, costruzioni di prove e testimonianze false, ecc. (come esempio contemporaneo ricordiamo le torture fatte dallo stato di polizia al G8 di Genova 2001 e alla scuola Diaz). Col processo Egidi si era avuto per la prima volta un’ammissione pubblica nel Paese che la tortura veniva correntemente impiegata, in quanto (“può essere considerata tortura forse un cazzotto?”, si domandò arrogantemente il p.m.) “tutti i detenuti, più o meno, vengono percossi, specie se si ostinano a negare … , e la tortura, se è ‘moderata’, non si vede perché non debba esser cosa lecita”.
Dal caso Egidi prese il via anche una commissione ministeriale d’inchiesta, nominata dal guardasigilli Zoli il 28/2/1952, la quale consegnò la sua relazione il 22/3/’54 al guardasigilli De Pietro. Poco dopo l’insediamento della commissione un penalista, con acuto spirito profetico, aveva scritto: “…la cosa peggiore che potrebbe attualmente succedere sarebbe proprio che la Commissione d’inchiesta dovesse, per mancanza di materiale concreto su cui portare il proprio giudizio, giungere a conclusioni contrarie a quelle di tutti gli esperti e i conoscitori della realtà della vita giudiziaria. Allora si che la polizia si sentirebbe impunita e autorizzata ad insistere nei deprecati metodi fascisti”. Difatti, la commissione finì col fare un lavoro meno inutile che dannoso, scoprendo soltanto 315 casi (dal 1945 al ’52); tale numero venne ulteriormente assottigliato per effetto di doppioni o di limiti di competenza fino a ridursi a 144 casi. La commissione si stimò quindi nelle condizioni di poter concludere che “il fenomeno di eccessi e abusi, da parte della polizia giudiziaria e a danno di persone indiziate di delitti, indubbiamente esiste, ma non con la frequenza e la gravità talvolta denunciate, forse sotto la spinta della polemica”. E, rincarando la dose, la relazione finale della commissione ritenne di “escludere che l’abuso abbia mai assunto l’importanza e la gravità di un vero e proprio sistema, come tale imputabile ad iniziativa e direttive di organi centrali o periferici. Trattasi invero di casi fortunatamente isolati, consistenti nella maggior parte in percosse, e quindi dovuti alla intemperanza dei singoli, la quale può trovare la sua spiegazione nell’ambiente e nel carattere individuale oltre che nella inadeguata preparazione di alcuni degli elementi…” La verità invece è tutt’altra; e ci si domanda che cosa abbia mai potuto accertare una commissione (per l’esattezza: “commissione ministeriale per accertare lo svolgimento della fase preliminare di procedimenti già definiti”) che adottò come metodo di indagine la richiesta scritta ad alcune autorità e organismi dello stato (parlamento, corti d’appello, direzione della PS, comando dei carabinieri, ministero della giustizia, ordini degli avvocati), limitando la propria attività ad aspettare che da tali organismi ed autorità (e dal privato che ne avesse il desiderio) fosse eventualmente pervenuta una segnalazione. È chiaro allora che la commissione fu boicottata (d’altronde già i fini e i poteri conferiti ad essa non potevano lasciar sperare in un effettivo lavoro a fondo di inchiesta); basti dire che la direzione della PS rispondeva con un secco rifiuto alla richiesta avanzata dalla commissione di fornire indicazioni sui casi riguardanti il personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, adducendo di non potere “esercitare un continuo controllo tecnico sull’attività svolta dagli organi di polizia giudiziaria”. Quando – fu osservato – con una certa qual ingenuità “la più sospettata” a torto o a ragione, era la Pubblica sicurezza. Sembrava dunque che, essa stessa, per prima, avesse dovuto sentirsi felice di potersi, forse doverosamente, certo signorilmente, sottoporre ad ogni possibile rilievo e controllo. È apparso chiaro, per contro, che essa non ha affatto gradito la nomina e l’intervento della Commissione, e che non ha inteso per nulla di facilitare quella sua opera di investigazione e di ‘accertamenti’ che, pure, le era stata demandata dal suo stesso Governo” – ammettendo cosi, aggiungiamo noi, implicitamente di avere non poco da perdere da un accertamento anche minimo, quale poteva essere quello “su richiesta” della commissione, dei fatti che la riguardavano. Altra prova dell’assoluta inattendibilità delle conclusioni della commissione risiede nella non-collaborazione degli avvocati, i quali non segnalarono nessun caso, confermando col loro silenzio la giustezza delle affermazioni che Piero Calamandrei aveva fatto alla camera nei giorni 27-28 ottobre 1948. Dopo aver ricordato del caso Fort il modo “con cui l’imputata era stata indotta a confessare, interrogandola ininterrottamente per 80 ore di seguito, impedendole di dormire, di distrarsi, di mangiare e di bere, tenendola inchiodata 4 giorni e 4 notti e più, sotto la luce accecante delle lampade concentrate su di lei” aggiunse: “ma il caso Fort […] non è isolato. […] una specie di inchiesta privata e discreta fra gli avvocati e magistrati: […] ha raccolto materiali impressionanti […]. Gli avvocati interpellati mi hanno risposto in via confidenziale, ma mi hanno fatto promettere di non dir pubblicamente i loro nomi, perché essi sanno che se, nel rivelare quei metodi, precisassero dati e circostanze, verrebbero a danneggiare i loro patrocinati: li esporrebbero a rappresaglie, a persecuzioni, forse a imputazioni di calunnia, perché di fronte alle loro affermazioni non si troverebbe il testimone disposto a confermare che quanto dice l’imputato è vero. Accade così che il difensore, anche quando sa che il suo patrocinato è stato oggetto di vera e propria tortura per farlo confessare, lo esorta a sopportare e a tacere, a non rivelare in udienza quei tormenti ai quali, in mancanza di prove, i giudici non credono”.
Con Piero Calamandrei concordava pienamente anche Lelio Basso, nel sostenere che i casi di cui si era venuti, in un modo o nell’altro, a conoscenza non erano casi isolati; cosi l’allora deputato del PSI scriveva all’allora deputato del PSDI, inserendo, giustamente, il discorso sulla tortura nel suo legittimo contesto, l’oppressione di classe: “Tu, che segui con diligente amore le vicende della vita giudiziaria italiana, sai che anche sulla base della legislazione vigente, quando sia arrestata per motivi comuni una persona appartenente a ceti sociali privilegiati, e uso la parola in senso molto lato, può avere la sicurezza di andare esente da mezzi coercitivi, anche se si ostinasse a negare. Ti immagini tu un diplomatico G., o una contessa B., o un monsignor L., o un industriale X, o un funzionario Y, sottoposti a questo trattamento? E questa sicurezza deriva ad essi dal costume millenario, che è sopravvissuto alla Rivoluzione Francese e sopravvive anche alla nostra Repubblica democratica, che la tortura per i reati comuni si applica solo agli humiliores e non agli honestiores, mentre per il crimen majestatis (oggi, in senso più lato, per i reati politici) come per l’eresia, che è reato di lesa maestà divina, omnes torquentur. […] come potrebbe […] il Governo prendere seriamente posizione contro l’impiego di metodi che costituiscono uno specifico mezzo di lotta contro i suoi avversari politici e sul cui impiego nei confronti di questi ultimi esso non ha mai avuto nulla da ridire? Si deve riconoscere, in sostanza, che la tortura, o se si preferisce l’uso di mezzi coattivi, è uno degli elementi particolari che concorrono a determinare quel tessuto di continuità storica della storia di uno stato poliziesco qual è quello italiano. La dichiarazione ormai famosa, di un funzionario della PS ad un intervistatore: “Non c’è bisogno di congressi. La polizia funziona abbastanza: bastano i confidenti e qualche mazzata ... ” trova riscontro in queste altre – raccolte – di un anziano appunto di PS: “Non ho mai sentito un criminale confessare, e allora se non si usano certi mezzi, anche che non lascino segni, i delitti non si scoprirebbero mai… sotto il fascismo si poteva fare quello che si voleva… ma oggi si deve stare molto attenti… bisogna trovare quei mezzi che non lascino segni…”. Molto più esplicito un ex questore, il quale, oltre 100 anni or sono scriveva: “È raro il caso che un individuo venga arrestato e non lo si percuota in modo orribile. La parte del corpo preferita dagli agenti di PS per offendere l’infelice, sono i fianchi. Quivi si danno pugni e calci terribili, senza timori che vengan fuori ecchimosi ed enfiazioni […]. Bisogna essere negli uffici di Questura e sentire quali grida, quali lamenti e quanti gemiti escono dalle camere di custodia dei detenuti! Una guardia prende l’arrestato per la testa e gli ottura possibilmente la bocca; un’altra lo tien stretto pei piedi, e due o tre altre, a seconda del bisogno che sentono di sfogare le loro frustrazioni ( pronti ad obbedire, senza usare il cervello…) che li divora, menan giù eroicamente pugni nel ventre e nei fianchi dell’infelice! Costui si dibatte, cerca di svincolarsi, soffre, si scuote ad ogni colpo come agitato dall’elettrico, ma tutto è inutile! Ogni resistenza è impossibile , a far cessare l’infame tortura […]. Agli spasimi di quei meschini le guardie rispondono con delle risate saporitissime e con delle bestemmie da trivio. Se poi all’arrestato non si chiude la bocca e quindi piange e grida, è ancora più maltrattato: riceve ceffoni, tirate d’orecchie, morsicature e bastonate.”
Oggi come ieri e ieri l’altro, la polizia tortura, bastona, maltratta. Regolarmente, ma non costantemente, non già perché non usi sempre questo trattamento (dipendendo la cosa dal temperamento del funzionario o del militare singolo), ma piuttosto perché non la pratica a tutti gli inquisiti. A uscirne indenni del tutto dalle caserme e questure d’Italia sono solamente gli honestiores di cui parla Basso: l’alta borghesia, i depositari stessi del potere che i poliziotti per loro amministrano. Tutti gli altri subiscono un certo grado di violenza nel contatto con la polizia, quando questa ne abbia una motivazione (che può essere la più varia, la più labile: raggiungere un successo, avere deciso un colpevole a priori ecc.): è solo questione di gradi. Difficilmente si adopreranno mezzi di torture vere e proprie ai danni di esponenti delle classi medie, mentre i predestinati ai trattamenti inquisitori sono i figli del sottoproletariato, coloro che, loro malgrado, “sono di casa” in questura o in commissariato, coloro che quando non siano pregiudizialmente classificati come delinquenti da poliziotti e magistrati, sono visti come conniventi e omertosi, la “plebaglia” in una parola (= “una massa di miserabili, oziosi, ignoranti, corrotti ed insieme astutissimi, che non sono i delinquenti propriamente detti, ma pericolosi quanto costoro, i quali per le loro abitudini grossolane ed abbiette, riescono di continua molestia e di pericolo agli abitanti onesti” -voce dell’Enciclopedia di Polizia). Del resto i nemici della polizia sono di 3 categorie: i sovversivi e facinorosi, i delinquenti, i poveri. Alla prima categoria appartengono tutti coloro che attentano all’ordine costituito, coloro che mettono in pericolo di rivolgimento la società, o più modestamente turbano (o li si giudica capaci di turbare) l’ordine pubblico: una categoria quindi interclassista. Perciò nella quiete della questura romana si picchiano due giornalisti dell’ Espresso perché rappresentanti di una rivista considerata “di sinistra (anticomunismo atlantico) “; o, sempre nel buio della questura della capitale, si tortura -sic et simpliciter- lo studente Antonino Russo, indiziato di reato per un attentato alla Boston Chemical, perché il padrone americano non si tocca; o, ancora, si ammazza di botte un ferroviere in una stanza della questura milanese e lo si butta giù da una finestra, in seguito ad “incidente tecnico”, perché anarchico. Certo non si arriva sempre alla violenza selvaggia, alle lesioni, alle percosse; dato che l’uso della violenza (prescindendo da un grado minimo di violenza e sopruso che si può dire connaturato all’esercizio stesso del mestiere di poliziotto in un paese in cui le leggi difendono solo chi le fa) è sempre legato al fine di ottenere un’ammissione, di estirpare una confessione, di ascoltare una rivelazione, non è sempre necessario per la polizia ricorrere a mezzi così brutali, che, oltre tutto, possono lasciare tracce; spesso basta la somministrazione accorta di una violenza diversa qualitativamente. Un dirigente della questura milanese -il capo dell’ufficio politico- che sarebbe di li a qualche mese divenuto celebre, nel maggio ’69 si sentiva muovere queste contestazioni da una giornalista nel corso di una “chiacchierata” (subdolamente utilizzata come intervista): “Gli interrogatori, poi, che sono chiacchieratine punteggiate da andate in trattorie, calcio, affari familiari, per 3, 5, 8 ore interrotte e riprese, e il poveretto costretto in tensione tutto il tempo. A volte un altro sbirro che invece arriva truce e fa: adesso se non canti ti mando a San Vittore, poi se la squaglia subito e il dattilografo commenta: dai, fai il bravo, dicci qualcosa, se no lui diventa un bruto, è un po’ nervoso. Il sonno che non vien concesso, seduti sulla sedia tutta la notte, con gli agenti che entrano, escono, fischiettano, battono a macchina ma senza darsi la pena di mascherare la finzione perché non infilano il foglio, o mi sbaglio? Che ne dice dottor Allegra?”, rispondendo con imbarazzato savoir faire: “Non sono verità, tutt’al più pause negli interrogatori per controllare un alibi. Preferirei che si dicesse che diamo schiaffoni. Io ho usato sempre molta considerazione, dopo due ore faccio sempre arrivare il caffè, sarà che sono generoso di natura, neppure dico chi lo offre. Dicono che siamo civili: ebbene, noi riteniamo di trovarci in un ambiente più civile qui al nord e perciò operiamo più civilmente…”. Assai meno interclassista, nella misura in cui la delinquenza può non essere un fatto di classe, la categoria seconda, i delinquenti, o meglio coloro che la polizia decide che debbano o possano essere tali; chiarissimamente, non rientrano fra i delinquenti tutti coloro che a causa di errori pacchiani e di sviste clamorose pur essendo parte della classe dominante finiscono per sbaglio incriminati da qualche giudice che non farà carriera. Per il resto, come la straordinaria vicenda (si deve ammettere che si trattava di un caso particolarmente ben riuscito di organizzazione della tortura) dei carabinieri di Bergamo illustra, anche esponenti della piccola e media borghesia possono -una volta che siano finiti nelle mani di questurini e carabinieri in caccia di colpevoli a confessione- venire -ma non tranquillissimamente, come gli sviluppi della vicenda hanno mostrato- strapazzati dai tutori dell’ordine e della legge, nei cui confronti per lo più nutrono servile paura e riverenziale timore. A Bergamo i torturati (27 persone in totale) dalla banda criminale del maggiore -promosso nel tempo trascorso, forse per i meriti acquisiti, a colonnello Siani, appartenevano appunto alla piccola e media borghesia oltre che al proletariato: vi si trovano infatti operai, impiegati, agricoltori, e vari “onorati cittadini e onesti professionisti” tra i quali, come raccontò in udienza il deputato Patrini, imperversando nella zona la banda Siani dell’arma benemerita, “non ve n’era uno che reputasse di essere sicuro. […] Nemmeno al tempo delle SS erano capitate cose del genere”. In effetti gli 11 carabinieri di Bergamo, decisi a far bella figura e verso il comando dell’arma (siamo nel 1964: De Lorenzo, dunque), e verso le “superiori autorità”, sottoposero tutti i malcapitati finiti sotto le loro grinfie, presi a casaccio nei paesi del bergamasco e del cremonese, ad un campionario di torture seicentesche riuscendo ad ottenere tutte le confessioni ambite, tanto che perfino la televisione portò alla ribalta il segugio di Bergamo che grazie alle sue personali capacità, validamente coadiuvato dai suoi subalterni, era riuscito a sgominare una pericolosa banda di malviventi… “Finii col dire che potevano accusarmi anche dell’assassinio di Kennedy, purché la smettessero”, dichiarerà al processo uno dei “malviventi”. Ma quello di Bergamo rappresentò un caso limite, non tanto per il sadismo degli inquisitori, quanto per il largo arco di classe toccato dal procedimento confessionalistico dei carabinieri: non è senza significato che i carabinieri siano stati scoperti, denunciati, condannati. Ciò è dovuto proprio, prima di ogni ulteriore considerazione, alla collocazione di classe dei torturati; ben altrimenti si è concluso il contemporaneo processo di Perugia, dove chi aveva subito le torture della polizia- pressoché identiche a quelle di Bergamo: il che dimostra che PS e carabinieri, al di là delle rivalità e delle diversità hanno studiato alle stesse scuole -essendo pastore e non, dunque, cittadino onorato e onesto professionista, non ha potuto godere del credito di cui hanno beneficiato i cittadini perbene del bergamasco (per i quali si è scomodato un deputato della DC: si trattava, con tutta probabilità di suoi elettori). Gli stessi atti di tortura, accertati dai giudici, contano assai diversamente a seconda che si sia infierito, com’è normale, sui servi-pastori della Sardegna (per la quale vicenda l’anormalità consisteva nel rinvio a giudizio deciso dai giudici isolani “in caccia di popolarità”, probabilmente avrà pensato molta gente perbene) o sui laboriosi cittadini della grassa Lombardia. Si possono ancora nutrire dubbi sul significato di classe della tortura, cosi come della giustizia e del potere di polizia?

Coi poliziotti torturatori di Sassari, siamo quindi nell’ambito della terza categoria, quella dei diseredati. Una vicenda estremamente significativa a tale proposito è quella che risale al 1945 quando un portiere di Napoli, Leone Savarese, presentò una denuncia contro un commissario di PS, il quale lo aveva fatto arrestare accusandolo di un duplice omicidio commesso in città. Nell’accusa del portinaio era scritto: “i funzionari e gli agenti, durante tutto questo periodo di tempo, nonostante che io confermassi la mia innocenza, mi sottoposero a sevizie e maltrattamenti inauditi. Sembrava una danza infernale. Tutti i mezzi coercitivi furono usati contro di me: un bastone di nerbo di bue, l’immissione di sale e pietre nella bocca, abluzioni continuate di acqua fredda, percosse a sangue, legature di mani e piedi. Ma il supplizio più atroce e feroce fu di cospargermi benzina sui piedi. Io strillavo come un ossesso ma le sevizie aumentavano. Anche della carta bruciata mi veniva messa sotto il naso e vicino le guance”. Per conseguenza, come dichiarava la sentenza del tribunale (ottobre 1946), “al suo ingresso nel carcere giudiziario […] il Savarese […] presentava una scottatura di 3° grado al piede destro […]. Interrogato dal Procuratore della Repubblica il Savarese lamentava di essere stato sottoposto a sevizie fasciste e maltrattamenti inauditi da parte di funzionari ed agenti della Questura […] culminate con le scottature al piede …”. Ma, prosegue la sentenza, pur non sussistendo “alcun dubbio sulla natura delle lesioni denunziate dal Savarese” poiché “il Savarese accusa, l’imputato [il commissario di PS] nega […] manca del tutto la prova che l’accusa del Savarese sia calunniosa; ma, nel contempo, difetta assolutamente anche la prova che l’assunto del denunciante risponda a verità”.
Ricordiamo anche il compagno Anarchico Giuseppe Pinelli ucciso dalla violenza sbirresca nel 1969.
Pinelli fu ucciso perché quel giorno, in questura, dichiarò che la strage di piazza fontana era stata fatta dagli apparati occulti dello stato (piano militare: strategia della tensione…).
La morte di Pinelli quindi fu causata dal tentativo di trovare un capro espiatorio per gli attentati di piazza Fontana.
Pinelli vive e lotta insieme a noi, le nostre idee non cambieranno mai !!
W L’Anarchia
28 giugno 2015: Allerta! Allerta! In Francia il parlamento ha approvato la legge sulla sorveglianza di massa che limita la libertà di espressione e di critica, una legge che dà più potere alle forze del disordine (trame geopolitiche…).
Questo testo non è sottoposto ad alcun copyright, persistendo nell’inimicizia verso ogni tipo di proprietà, soprattutto quella del sapere.
CULTURA DAL BASSO CONTRO I POTERI FORTI E I LORO SERVI INFAMI
Lo Stato è nato dalla forza militare;
si è sviluppato servendosi della forza militare;
ed è ancora sulla forza militare che
logicamente deve appoggiarsi per mantenere
la sua onnipotenza.
Dal “Manifesto internazionale anarchico contro la guerra” (1915)
Rsp (individualità Anarchiche)